|
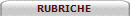

.

.

.

.
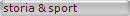
.
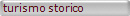
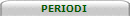
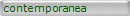
.

.
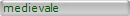
.


.
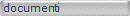
.
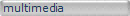
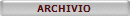

|
N. 25 - Gennaio 2010
(LVI)
IL GRANDE CROLLO DEL 1929
La crisi del capitalismo: cause e soluzioni
di Cristiano Zepponi
La
borsa
di
New
York
aprì
gli
scambi,
come
sempre,
alle
dieci
del
mattino,
il
29
ottobre
1929.
Ma,
stavolta,
si
scatenò
un
disperato
assalto
per
la
vendita
di
azioni
e
depositi
bancari,
ad
ogni
prezzo.
Sarebbe
passato
alla
storia
come
il
momento
culminante
(insieme
alla
giornata
del
24,
“giovedì
nero”)
del
“grande
crollo”:
un
evento
insieme
sintomatico
del
malessere
serpeggiante
nell’economia
mondiale
e
degli
squilibri
verificatisi
in
precedenza.
Il
clima
che
respirava
la
borghesia
americana,
nei
“ruggenti
anni
‘20”,
era
improntato
all’ottimismo
ed
alla
fiducia
in
una
crescita
illimitata
e
indefinita
di
ricchezza
e
benessere.
Nessun
freno
politico
limitò,
in
alcun
modo,
la
produzione,
in
omaggio
alla
dilagante
teoria
liberista;
né
vi
fu
alcun
ostacolo
all’incredibile
ondata
di
euforia
speculativa
che
la
Borsa
visse
negli
anni
precedenti,
incoraggiata
dalla
prospettiva
di
facili
guadagni
attraverso
la
compravendita
delle
azioni.
Le
fondamenta
del
sistema
erano
evidentemente
assai
fragili.
E,
infatti,
alcune
avvisaglie
ci
furono,
nel
biennio
1920-’21
e
più
tardi,
nel
1927.
Da
quell’anno
gli
investimenti
non
aumentavano
più,
come
i
salari
e
gli
stipendi,
le
vendite
di
automobili
addirittura
diminuivano:
ma
la
speculazione
diede,
ancora
per
due
anni,
l’illusione
di
un
progresso
continuo,
inarrestabile.
Come
fragili
furono
le
basi
dell’intero
processo
di
espansione
economica
degli
USA
negli
anni
’20.
La
domanda
sostenuta
di
beni
di
consumo
(in
massima
parte
durevoli,
tendenti
quindi
alla
“saturazione”
del
mercato)
favorì
infatti
la
formazione
di
una
capacità
produttiva
sproporzionata
alle
possibilità
di
assorbimento
del
mercato
interno.
A
questo
problema
si
reagì
in
due
modi:
sviluppando
il
credito
ai
privati,
sostenuto
da
grandi
battages
pubblicitari,
incitando
l’acquisto
immediato,
anche
a
costo
di
gravare,
a
lungo
termine,
sui
redditi;
e
aumentando
le
esportazioni,
specie
nel
vecchio
continente,
accompagnate
da
elevate
barriere
doganali
in
patria,
fino
a
creare
uno
stretto
rapporto
di
interdipendenza
con
la
ripresa
europea.
L’Europa,
insomma,
otteneva
finanziamenti
dagli
Stati
Uniti
e
sua
volta
ne
alimentava
lo
sviluppo
con
le
importazioni.
L’America,
in
particolare,
elargì
6400
miliardi
di
dollari
all’economia
mondiale
tra
il
1924
ed
il
1929,
in
larga
misura
a
Germania
ed
Europa
dell’est.
Ma
anche
questo
meccanismo
risultava
pericoloso,
perché
i
crediti
statunitensi
erano
generalmente
erogati
da
banche
private
e
legati
a
soli
calcoli
di
profitto.
Ogni
dirottamento
dei
capitali
verso
altre
operazioni
avrebbe
insomma
avuto
pesanti
conseguenze
sulla
produzione
industriale
americana,
ormai
dipendente
dalle
importazioni
europee.
E
questo
fu
esattamente
ciò
che
accadde.
I
crediti
furono
dirottati,
specie
durante
il
1928,
verso
le
più
redditizie
operazioni
speculative
della
Borsa.
Si
fondarono
società
esclusivamente
finanziarie
(“investments
trusts”)
al
solo
scopo
di
acquistare
le
azioni
e
rivenderle
a
prezzo
superiore.
Si
costituirono
così
immense
ricchezze
che
rappresentavano
un
capitale
esclusivamente
azionario,
senza
una
contropartita
di
produzione;
il
volume
dei
titoli
in
movimento
passò
da
433
a
757
milioni,
il
valore
globale
di
quotazione
in
Borsa
dei
titoli
negoziati
allo
Stock
Exchange
da
27 a
67
miliardi.
L’
indice
della
produzione
industriale
americana,
orfana
dell’export
oltreoceano
in
caduta,
cominciò
a
scendere
già
nell’estate
del
’29.
In
settembre,
il
corso
dei
titoli
di
Borsa
raggiunse
i
massimi
livelli.
Dopo
alcune
settimane,
gli
operatori
cominciarono
a
liquidare
i
propri
pacchetti
azionari
per
realizzare
i
guadagni
ottenuti:
il
24
ottobre
ne
furono
scambiati
13
milioni;
il
29
si
arrivò
a 16
milioni.
La
corsa
alle
vendite,
naturalmente,
generò
una
caduta
del
valore
dei
titoli,
stabilizzatisi
a
metà
novembre
su
valori
più
o
meno
dimezzati,
con
conseguenze
disastrose
su
ogni
piano.
Il
24
ottobre
si
suicidarono
a
New
York
undici
agenti
di
borsa.
La
prima
reazione
delle
banche,
principali
proprietarie
di
pacchetti
azionari,
fu
di
restringere
il
credito
al
consumo.
Nondimeno,
molte
di
esse
fallirono.
Le
piccole
imprese
industriali
e
commerciali
finirono
rovinate
dall’accumularsi
delle
scorte
dovuto
alla
precedente
sovrapproduzione.
Quelle
di
dimensioni
maggiori
reagirono
riducendo
la
produzione,
e,
semplicemente,
le
spese;
salari,
materie
prime,
lavoratori
ne
furono
colpiti.
In
questo
modo,
si
creò
una
spirale
per
la
quale
i
bassi
salari
(comuni
anche
al
settore
agricolo,
in
crisi
da
qualche
anno)
e la
disoccupazione
diminuivano
i
consumi,
la
cui
caduta
colpiva
le
imprese
spingendole
ad
altri
licenziamenti
e
altri
tagli.
I
salari,
in
particolare,
diminuirono
in
media
del
40%.
I
prezzi,
del
20%.
Le
importazioni
statunitensi
passarono
dai
4400
mln.
di
dollari
nel
’29
ai
1323
mln.
nel
1933,
le
esportazioni
nello
stesso
periodo
da
5240
a
1610
mln.
Il
livello
di
vita,
di
cui
la
borghesia
americana
era
tanto
fiera,
semplicemente
crollò.
La
disoccupazione,
dagli
1,5-2,5
mln.
del
1929,
balzò
agli
oltre
11,4-14,7
del
’32.
Il
flusso
creditizio
verso
l’estero,
inutile
a
dirsi,
si
interruppe
bruscamente
alla
fine
degli
anni
’30
per
quanto
riguarda
i
prestiti,
nel
corso
del
’32
per
quanto
riguarda
gli
investimenti.
Gli
Stati
Uniti,
invece
di
sobbarcarsi
i
costi
e le
responsabilità
connessi
al
ruolo
di
potenza
egemone
sul
piano
economico,
cercarono
innanzitutto
di
difendere
la
loro
produzione.
Rimpatriarono
massicciamente
i
crediti
erogati
all’estero,
danneggiando
pesantemente
soprattutto
la
Germania
e
l’Austria,
oltre
che
l’Inghilterra;
in
più,
reputarono
giusto
istituire,
il
primo
giugno
1930,
un’alta
tariffa
doganale,
detta
“Harvley-Smoot”
(dal
nome
degli
ideatori,
due
membri
del
Congresso),
che
aumentò
tutti
i
diritti
al
50%
inasprendo
il
protezionismo
e
inducendo
gli
altri
Stati
a
fare
lo
stesso.
Imposero,
cioè,
severi
limiti
all’import
proprio
nel
momento
di
disperato
bisogno
per
gli
altri
Stati
di
estinguere
i
propri
debiti
in
dollari
attraverso
le
vendite
sul
più
ricco
mercato
del
mondo.
L’America
Latina
fu,
per
il
suo
ruolo
di
fornitrice
di
materie
prime
agli
USA,
la
prima
ad
essere
colpita,
e
fin
dal
dicembre
1929
Argentina,
Uruguay
( ma
anche
Australia)
abbandonarono
il
corso
aureo,
svalutando
la
moneta
per
ridare
forza
all’export.
Nel
corso
del
‘31,
anche
l’economia
europea
crollò.
Fallirono
in
primo
luogo,
anche
sul
vecchio
continente,
le
strutture
bancarie:
la
“Kreditanstalt
fur
Handel
und
Gewerbe”
austriaca,
la
“Danatbank”
tedesca,
per
fare
degli
esempi.
In
giugno,
la
crisi
si
estese
all’Inghilterra.
All’inizio
del
1932
giunse
in
Italia,
Francia,
Belgio,
Olanda.
Solamente
l’Unione
Sovietica,
alle
prese
con
i
Piani
Quinquennali
e
chiusa
all’economia
di
mercato,
fu
risparmiata;
ed
alcuni
storici
(come
Hobsbawm),
addirittura,
le
assegnano
il
merito
di
aver
aperto,
con
il
suo
esempio,
la
via
all’intervento
statale
nelle
economie
occidentali.
Per
rispondere
alle
iniziative
d’oltreoceano,
tanto
la
Germania
quanto
la
Francia
misero
sotto
controllo
il
commercio,
imponendo
quote
sull’import
e
introducendo
quote
di
permuta
diretta
coi
partner
commerciali.
Nel
novembre
del
’31
la
Gran
Bretagna
impose
dazi
del
50%
su
ventitré
diverse
categorie
merceologiche,
per
poi,
nella
British
Empire
Conference
di
Ottawa
(luglio-agosto
’32)
fissare
un
canale
“preferenziale”
di
circolazione
delle
merci.
A
cosa
ciò
potesse
portare
è
molto
chiaro.
Il
valore
del
commercio
mondiale
registrò
una
contrazione
del
60,9%
tra
1929
e
1933,
il
volume
scese
del
25,4%.
La
produzione
industriale,
in
particolare,
ne
risultò
strangolata:
scese
del
40%
in
Germania
nel
corso
di
quattro
anni,
ed
in
Francia,
ancora
nel
’38,
si
produceva
un
terzo
di
acciaio
in
meno
rispetto
ad
un
decennio
prima.
I
risvolti
più
onerosi
furono,
come
sempre,
quelli
sociali:
negli
Stati
Uniti
fu
colpito
dalla
crisi
un
lavoratore
su
quattro,
in
Germania
due
su
cinque.
Nei
pochi
paesi
dotati
di
un
sistema
previdenziale
l’assistenza
pubblica,
per
la
scarsità
di
risorse
di
fronte
ad
un
tale
problema,
cessò
di
esistere.
Si
assistette
allora
alla
crescita
esponenziale
di
piccoli
centri
di
assistenza,
organizzati
da
volontari,
nei
due
continenti.
Le
comunità
operaie
tentarono
invece
di
fare
affidamento
sulle
proprie
forze.
I
crimini
contro
la
proprietà,
di
qualunque
natura,
balzarono
alle
stelle.
L’assenza
di
una
leadership
nell’economia
mondiale
si
fece
sentire
duramente.
I
vari
Stati
tentavano
di
difendersi,
ognuno
chiuso
nel
proprio
nazionalismo
economico,
finendo
per
danneggiarne
altri.
La
sterlina,
la
moneta
di
riferimento
del
circuito
economico
mondiale,
fu
svalutata
nel
1931
per
renderla
più
competitiva;
gli
Stati
Uniti,
seguendo
una
logica
concorrenziale,
fecero
lo
stesso
due
anni
dopo.
A
Losanna,
nel
1932,
gli
europei
decisero
addirittura
di
abolire
le
riparazioni
del
conflitto;
di
fronte
a
questa
decisione,
il
governo
Hoover
pretese
l’impossibile:
che
l’Europa
pagasse,
nonostante
tutto.
Il
risultato
fu
che
i
paesi
d’oltreoceano
decisero,
unilateralmente,
di
non
farlo
più.
Scelsero
questa
via
Francia,
Gran
Bretagna,
Italia
e in
breve
tutti
gli
altri.
Con
una
sola
eccezione:
la
Finlandia.
Più
tardi,
con
il
Johnson
Act
del
13
aprile
1934,
gli
States
tagliarono
i
ponti
col
mondo,
vietando
ogni
prestito
ai
paesi
che
non
avessero
pagato
i
loro
debiti
di
guerra.
L’ultima
grande
speranza
per
una
reazione
collettiva
e
condivisa,
la
Conferenza
economica
mondiale
di
Londra
datata
giugno
1933,
fallì
miseramente.
Nel
museo
di
storia
naturale
di
Kensington,
dove
questa
si
teneva,
il
veto
dell’America
ad
entrare
in
un
sistema
monetario
fisso
ne
decretò
il
fallimento
dopo
appena
tre
settimane.
Le
parole
di
Raymond
Moley,
amico
personale
di
Roosevelt
e
inviato
americano
al
convegno,
indicano
perfettamente
la
strada
che
si
preferì
imboccare:
“ Il
programma
di
riassestamento
(…)
dev’essere
essenzialmente
interno”.
La
convertibilità
aurea
della
sterlina,
simbolo
e
strumento
del
potere
economico
inglese,
fu
sospesa
nello
stesso
anno.
Lo
shock
per
l’avvenimento,
nel
resto
del
mondo,
fu
enorme.
Tramontava,
improvvisamente,
una
potenza
secolare,
abbandonando
la
sua
leadership.
Di
fronte
a
questo,
e ad
altri
tragici
avvertimenti
che
dimostravano
come
la
crisi
non
fosse
transitoria,
né
che
si
potesse
fare
affidamento,
come
fin’allora
si
era
erroneamente
ritenuto,
sulla
capacità
“risanatoria”
del
mercato,
si
diffuse
la
convinzione
che
solo
altri
tipi
di
interventi,
di
tipo
strutturale,
avrebbero
potuto
interrompere
la
crisi.
Lo
stesso
segretario
americano
al
tesoro,
Andrew
Mellon,
era
stato
un
sostenitore
dell’inazione;
e
così
Herbert
Hoover,
il
già
citato
presidente
americano
del
periodo
1929-1933,
che
riteneva
di
poter
salvare
la
situazione
agendo
sul
piano
psicologico,
e
che,
nel
tentativo
di
restituire
la
fiducia
scomparsa,
andò
incontro
ad
un
pesante
fallimento,
alimentando
peraltro
un
diffuso
clima
di
apatia
e
scoraggiamento.
I
principi
classici
della
scuola
economica
liberale,
applicati
in
pratica
da
tutti
gli
Stati,
non
ebbero
quindi
alcun
effetto;
il
mito
del
pareggio
del
bilancio,
in
particolare,
compresse
ulteriormente
la
domanda
interna.
Era
chiaro,
ormai,
che
urgevano
rimedi
non
ortodossi.
Inizialmente,
questi
furono
fondamentalmente
due:
la
deflazione,
appunto,
fortemente
avversata
dall’autore
di
“Occupazione,
interesse
e
moneta”
John
Maynard
Keynes,
applicata
in
Germania
con
Bruning
(1930-’32)
ed
in
Francia;
volta
a
contenere
la
spesa
dello
Stato
comprimendo
salari
e
stipendi,
correva
il
rischio
di
scatenare
la
crisi
sociale
(puntualmente
verificatasi,
rispettivamente
con
l’ingresso
dei
nazisti
nel
Reichstag
e
con
la
vittoria
del
Fronte
Popolare
nel
’36).
In
secondo
luogo
il
controllo
degli
scambi,
attuato
in
Sud
America,
Europa
centrale
e
balcanica,
Germania
(dopo
il
1933)
e
volto
a
risanare
nel
più
assoluto
isolamento
l’economia,
isolandosi
dal
mercato
mondiale:
in
breve,
il
produttore
straniero
che
attuava
una
vendita
in
una
di
queste
nazioni
doveva
obbligatoriamente
reinvestire
il
guadagno
all’interno
del
circuito
economico
di
quel
paese;
quest’ultimo
poteva
così
stabilire
il
proprio
dominio
sui
vicini,
pressati
dalla
crisi
e
costretti
quindi
a
vendere
i
propri
prodotti
a
qualunque
condizione.
Il
terzo,
e
ultimo
metodo
consisteva
nell’aumentare
la
quantità
di
moneta
in
circolazione,
e
soprattutto
nel
manovrare
in
senso
espansivo
la
spesa
pubblica
accettando
anche
di
infrangere
il
tabù
liberale
del
pareggio
del
bilancio
(anche
a
costo
di
arrivare
al
deficit,
secondo
la
politica
del
deficit
spending).
Nonostante
sia
stato
adottato
in
più
paesi
(
l’Inghilterra
e la
Francia
del
Fronte
Popolare,
i
Paesi
scandinavi,
in
forma
particolare
l’Italia
fascista)
il
caso
americano
resta,
senza
dubbio,
quello
più
noto,
oltre
che
più
rilevante
per
il
successivo
decorso
della
teoria
economica.
La
richiesta
di
politiche
attive,infatti,
si
diffuse
enormemente
anche
in
America:
è
per
questo
che,
nel
novembre
1932,
Franklin
Delano
Roosevelt
vinse
facilmente
le
elezioni
(
stracciando
Hoover
con
22.822.000
voti
contro
15.762.000)
divenendo
il
nuovo
presidente
degli
Stati
Uniti
d’America.
Il 4
marzo
del
’33,
nel
discorso
inaugurale,
dichiarò:
“Questa
grande
nazione
(…)
rivivrà
e
sarà
di
nuovo
prospera
(…)
Lasciatemi
affermare
con
forza
la
mia
convinzione:
la
sola
cosa
che
abbiamo
da
temere
è la
paura.”
Capì,
e fu
il
suo
merito,
di
trovarsi
di
fronte
ad
un
trauma
sociale
collettivo
senza
precedenti.
I
suoi
primi
cento
giorni
furono
una
frustata,
un’iniezione
di
fiducia,
riassumibile
col
passaggio
dallo
Stato
liberale
a
quello
interventista
in
materia
economica:
il
New
Deal
(
“nuovo
corso”),
prodotto
dell’empirismo
senza
un
piano
accuratamente
concertato,
venne
alla
luce
così,
col
contributo
fondamentale
del
presidente
e
del
suo
“brain
trust”
(
Moley,
Tugwell,
Warren,
Berle).
L’entusiasmo,
la
sensazione
di
ripartire
coinvolsero
tutti.
Le
prime
misure
furono
prese
a
sostegno
delle
banche
(
“Emergency
Banking
Bill”),
per
decretare
la
fine
del
proibizionismo,
per
tagliare
salari
e
pensioni
del
15%;
fu
creato
un
programma
federale
di
sussidi
per
i
disoccupati;
fu
svalutato
il
dollaro,
approvate
leggi
per
il
controllo
della
speculazione
in
Borsa;
ma,
soprattutto
furono
creati
alcuni
organismi
di
particolare
rilevanza:
-la
Farm
Credit
Administration
per
l’aiuto
agli
agricoltori;
-la
CWA
(Civil
Work
Administration)
per
amministrare
i
lavori
pubblici;
-il
NIRA
(National
Industrial
Recovery
Act)
per
il
sostegno
delle
rivendicazioni
operaie,
e
per
la
ripresa
industriale;
-la
TVA
(Tennessee
Valley
Auhorithy),
organismo
pubblico
per
la
ripresa
economica
dell’omonima
area;
-l’AAA
(Agricultural
Adjustment
Act)
per
favorire
la
ripresa
dei
prezzi
agricoli.
La
dura
opposizione
dei
conservatori,
espressa
nei
ripetuti
dinieghi
per
incostituzionalità
della
Corte
Suprema
alle
riforme
del
New
Deal,
fu
il
principale
ostacolo
da
superare.
Per
vincerla,
Roosevelt
fu
costretto
a
proporre
la
nomina
di
nuovi
giudici.
Bastò
agitare
questo
spauracchio,
per
avere
partita
vinta.
Con
il
successivo
ritiro
di
molti
dei
suoi
membri,
la
Corte
Suprema
rimosse
tutti
gli
ostacoli
costituzionali
all’intervento
dello
Stato
federale
nel
sistema
economico.
Il
New
Deal
era
realtà.
Pur
introducendo
il
dirigismo,
le
riforme
non
intaccarono
i
valori
basilari
del
mercato:
il
profitto
ne
rimase
il
fine
ultimo.
Per
quanto
la
grande
trasformazione
del
capitalismo
rimase
un
fenomeno
interno
al
sistema,
Roosevelt
ebbe
il
merito,
e la
forza,
di
diffondere
un
clima
meno
rassegnato,
più
coinvolgente
e
ottimista
in
un
Paese
fortemente
traumatizzato.
Da
quel
momento
in
poi,
inoltre,
lo
Stato
divenne
soggetto
attivo
dell’espansione
economica,
apportando
alcune
limitazioni
alle
scelte
dei
privati
pur
senza
snaturarne
l’autonomia;
dopo
il
secondo
conflitto,
tutti
i
governi
occidentali
faranno
lo
stesso.
Che
poi
il
piano
non
riuscì
completamente
negli
intenti,
è
ormai
certo.
La
produzione
industriale,
ad
esempio,
non
aveva
ancora
raggiunto,
dieci
anni
dopo,
i
livelli
del
’29.
“L’americano
uscì
da
una
crisi
che
l’aveva
colpito
più
duramente
della
guerra.
Ne
uscì,
nulla
di
più.
Il
suo
ottimismo
ricevette
un
tale
colpo
che
egli
rimase
ripiegato
su
se
stesso.”
Ne
uscì,
come
tutti
gli
altri,
con
la
guerra
che,
in
vari
modi,
la
crisi
aveva
nel
frattempo
provveduto
a
generare.

|
|
|
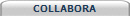
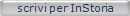
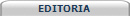
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
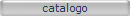
.
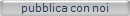
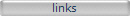
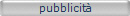
InStoria.it



|