Pittura dell’esplorazione
Rotte dell’arte tra storia e memoria
di Fabrizio
Mastio
La storia può essere interpretata
come un lungo viaggio contrassegnato
da partenze, soste e ritorni?
L’arte, ancora una volta, può
offrire una lettura interpretativa
ed essere letta come un diario di
bordo del perpetuo incedere degli
eventi. Un percorso può rinvenirsi
in un autentico capolavoro risalente
al II o I secolo a.C., custodito
presso il Museo Nazionale
Archeologico di Palestrina, il
Mosaico del Nilo, o
Mosaico nilotico di Palestrina
(431×585 cm). Anche se non
ascrivibile alla pittura, l’opera,
realizzata da autore ignoto, rimanda
alle Storie di Erodoto, dove,
nel II libro, viene fornita un’ampia
trattazione dell’Egitto e del Nilo.

Il fiume non rappresenta
esclusivamente un elemento
geografico, ma anche l’essenza di
una civiltà millenaria e la
fertilità. Il mosaico, osservabile
dalla parte superiore a quella
inferiore, raffigura l’Alto e il
Basso Egitto dell’epoca
greco-romana. Erodoto, nelle Storie,
fa riferimento alle cime dalle quali
sorgerebbe il Nilo: “Quanto alle
sorgenti del Nilo nessun Egiziano,
Libico o Greco venuto a colloquio
con me sostenne mai di conoscerle,
tranne lo scriba del sacro tesoro di
Atena, nella città di Sais, in
Egitto; ma quando costui mi disse di
conoscerle con certezza, ebbi
l’impressione che mi stesse
prendendo in giro. Parlava infatti
di due monti dalle cime aguzze
situati fra le città di Siene nella
Tebaide e di Elefantina, detti Crofi
e Mofi; le sorgenti del Nilo, che
sono inesplorabili, scaturirebbero
appunto in mezzo a questi due monti:
metà dell’acqua si riverserebbe a
nord, verso l’Egitto, l’altra metà a
sud, verso l’Etiopia”.
Nella sezione superiore compaiono,
in effetti, delle cime montuose,
probabilmente l’Acrocoro etiopico,
popolate da pigmei, dediti alla
caccia, in un mondo all’epoca
inesplorato. Vengono raffigurate
varie specie di animali che
riconducono il territorio immaginato
all’Egitto, anche per la presenza di
ippopotami, coccodrilli, pitoni,
rinoceronti africani, orsi, iene,
tartarughe e lontre, babbuini,
cinghiali e ghepardi: un vero
atlante storico-geografico. La
rappresentazione della caccia
all’ippopotamo da un’imbarcazione
egizia è accompagnata da una
bucolica scena di un simposio con un
pergolato ornato da grappoli d’uva.
Pastori, contadini e militari
popolano paesaggi naturali e urbani,
disegnando una geografia sociale.
Dal Nilo emerge la vita, tra realtà,
rituale e mito.
La realtà è presente nella caccia,
nell’agricoltura e nelle armature
dei soldati; il rituale nel
simulacro portato a spalla da un
gruppo di servitori; il mito, nella
raffigurazione di una sfinge che
osserva lo spettatore. L’opera
traccia un itinerario che pare
delineare un percorso evolutivo e
non esclusivamente spaziale: dalle
terre quasi disabitate si giunge
gradualmente verso la comparsa di
un’architettura urbana,
caratterizzata dallo scorrere della
vita quotidiana e dallo svolgimento
di attività agricole, di navigazione
e pesca, fino alle mura di quella
che, presumibilmente, può essere la
città di Alessandria d’Egitto,
adagiata sul delta del Nilo.
Il mosaico riproduce, inoltre, il
tema delle piene fluviali,
manifestazione della ciclicità della
vita e del complesso equilibrio che
regola il rapporto tra esistenza
umana e natura, come confermato da
Erodoto:“Quando il Nilo ha
inondato il paese, al di sopra delle
acque si vedono solo le città,
simili pressappoco alle isole del
Mar Egeo: giacché tutto il resto
dell’Egitto diventa un mare, e
solamente le città ne emergono”.
Il Mosaico nilotico potrebbe essere
letto come un percorso geografico,
partendo dall’alto degli speroni
rocciosi dell’antica Nubia fino alle
acque azzurre del porto di
Alessandria, o come un itinerario
storico-evolutivo, dalle origini e
da una dimensione primordiale,
rinvenibile nella parte superiore
dell’opera, fino a una società
maggiormente stratificata ed esposta
verso il mondo.
Dall’Antico Egitto il viaggio
esplorativo può continuare
attraverso le diverse prospettive
interpretative rinvenibili nelle
opere di tre artisti appartenuti a
epoche diverse, secondo un ordine
non meramente cronologico, ma
tematico: Il primo sbarco di
Cristoforo Colombo in America (1862)
di Dióscoro Teófilo Puebla Tolín (Fernal
de Fernamental, 25 Febbraio 1831 -
Madrid, 24 Ottobre 1901), Il
Geografo (1668-69 circa) di Jan
Vermeer (Delft, 31 ottobre 1632 -
Delft, 15 dicembre 1675) e
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo? (1897) di Paul Gauguin
(Parigi, 7 giugno 1848 - Hiva Oa, 8
maggio 1903). Queste opere
attraversano confini geografici e
concettuali, dipingono partenza e
destinazione, differenza e identità,
dubbio e certezza.
L’esplorazione nella pittura storica
di Dióscoro Puebla
Dioscoro Puebla, esponente
dell’eclettismo, ha abbracciato
diversi stili pittorici, dal
classicismo all’orientalismo, con
una produzione artistica
caratterizzata da varietà tematica e
formale,
Il primo sbarco di Cristoforo
Colombo in America (1862),
classico esempio di pittura storica
di stampo celebrativo, ricostruisce
l’approdo di Cristoforo Colombo
all’Isola di Guanahani, poi
denominata San Salvador, il 12
ottobre 1492. Il dipinto, olio su
tela di 330x545 cm, custodito presso
il Museo del Prado di Madrid,
costituisce una sintesi di
storicismo contraddistinto dal
connubio di orgoglio religioso,
patriottismo e glorificazione.
%20in%20America%201862.jpg)
Cristoforo Colombo occupa la scena
centrale della tela e,
simbolicamente, la terra e il cielo:
con lo sguardo scruta l’etere col
drappo innalzato in maniera
simmetrica dalla mano sinistra,
mentre la mano destra scuote il
suolo con la spada. Il rosso porpora
delle vesti del navigatore genovese
risaltano rispetto agli altri
elementi cromatici. Il marinaio, in
basso a destra, abbraccia la terra
americana, quasi rivendicandone il
possesso, mentre il frate sulla
sinistra con in mano un crocefisso
rappresenta l’opera di
evangelizzazione. Sulla sinistra, le
popolazioni locali, seminude,
emergono dalla vegetazione con
aspetto dimesso e impaurito.
Dal dipinto traspare volontà di
dominio e conquista con la sottesa
giustificazione del diritto al
dominio sul Nuovo Mondo. Sullo
sfondo si stagliano le caravelle,
ancorate nelle calme acque oceaniche
sormontate dal tenue azzurro del
cielo. La centralità dell’approdo
non appare casuale. Gli autoctoni,
occupano una porzione residuale del
dipinto, in un contesto privo della
rappresentazione di chiari simboli
della cultura locale. L’opera può
essere interpretata come un
manifesto propagandistico del
dominio coloniale in una dimensione
emotiva carica di dramma,
esaltazione e sorpresa. Gli
indigeni, descritti da Colombo con
la locuzione“genti ignude”
secondo la parafrasi di Las Casas,
rende chiaro il rimando a una
classificazione e non esclusivamente
a una descrizione.
Dioscoro Puebla ripropone in chiave
estetica il fatto che gli autoctoni,
in base al metro con cui nella
cristianità latina medievale si
giudicava il grado di civiltà di una
popolazione, non erano cittadini di
una società civile e tale
constatazione avrebbe costituito,
infatti, l’assegnazione di quelle
terre alla Corona di Spagna.
L’esplorazione nella pittura
silenziosa di Jan Vermeer
Dalla vastità oceanica agli ambienti
domestici di Vermeer, il viaggio non
trova interruzione, ma un percorso
differente. Il pittore del Secolo
d’Oro olandese dipinge Il
Geografo, olio su tela del
1668-69 circa, di 53x46,5 cm,
custodito presso il Städelsches
Kunstinstitut und Städtische Galerie
di Francoforte. L’opera,
analizzabile contestualmente a un
altro dipinto dello stesso autore,
L’Astronomo (1668), similare
per affinità estetica e concettuale,
raffigura una scena ambientata in un
ambiente domestico dove un geografo,
con abbigliamento accademico dai
colori blu, rosso e bianco, i
capelli lunghi e sguardo rivolto
verso il vuoto, in posa meditativa,
appare immerso fra voluminose carte
geografiche. Il drappeggio morbido
del copritavolo e le pieghe delle
vesti conferiscono dinamicità al
protagonista. Nella stanza, luce e
ombra si compenetrano, mettendo in
evidenza il protagonista della
scena, gli strumenti e le carte
geografiche. La luce proviene dalla
finestra, collocata sulla sinistra
della stanza, e penetra fiocamente
nello studio. Il geografo tiene la
mano sinistra appoggiata sul tavolo
e sulla destra un compasso, mentre,
in piena contemplazione, sembra
scrutare l’orizzonte o, forse,
l’ignoto. Se lo sfondo del dipinto
fosse il ponte di una nave delle
Compagnie delle Indie Orientali, non
vi sarebbe differenza.
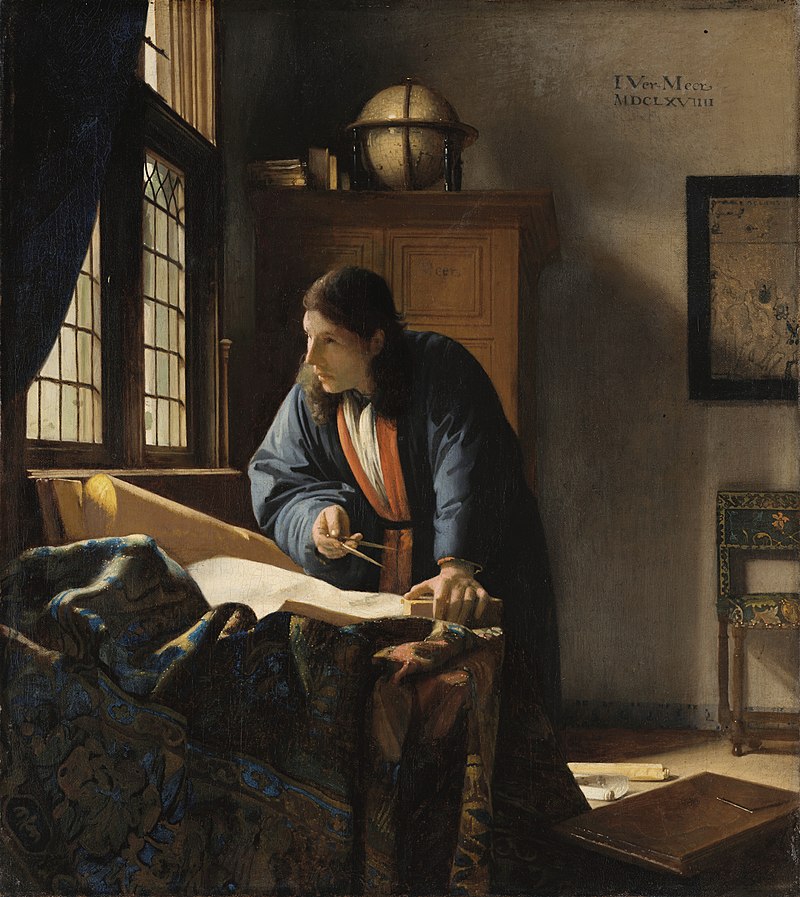
Nell’opera, le onde del pensiero si
infrangono sugli scogli del mare e
le pieghe del drappo policromatico e
delle vesti, che paiono raffigurare
il moto ondoso, potrebbero essere
merci depositate in una stiva. Le
carte geografiche ornano il tavolo
da lavoro e il pavimento, mentre un
mappamondo, posto in cima
all’armadio insieme ad alcuni tomi,
rispecchia fedelmente quello
realizzato nel 1618 da Jodocus
Hondius, membro di una famiglia di
cartografi. Sul muro è appesa una
carta geografica dei mari,
corrispondente a quella di Willem
Jansz. Blaeu. Poco sopra, appare la
firma del pittore. Gli strumenti
utilizzati dallo scienziato sono
riprodotti in modo preciso rispetto
a quelli effettivamente esistenti
all’epoca di Vermeer.
Nel dipinto il pensiero si
materializza, configurandosi come
un’allegoria della scienza. Nella
rappresentazione emerge chiaramente
la fede nel progresso e il desiderio
di esplorazione: pensiero,
equilibrio e metodo sembrano solcare
i mari della conoscenza.
L’esplorazione nella pittura esotica
di Gauguin
I luoghi dell’arte non costituiscono
esclusivamente un percorso
geografico, ma anche un itinerario
esistenziale. Paul Gauguin,
primitivista e simbolista,
rappresenta uno di quegli artisti
che non affronta i mari per spirito
di conquista, ma per trovare un
rifugio da una società che non sente
appartenergli. Cerca nell’esotismo
un itinerario che non è fuga fine a
se stessa, ma ricerca di una diversa
dimensione interiore, probabilmente,
non scoperta, ma riscoperta del sé
attraverso il contatto con culture
distanti dal Vecchio Mondo.
L’artista francese affronta quasi un
tragitto inverso rispetto a quello
descritto da Dioscoro Puebla.

Nel dipinto Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?, olio su
tela del 1897-1898, di 139,1x374,5
cm., custodito presso il Museum of
Fine Arts di Boston, attraverso il
titolo pone già domande dal sapore
teleologico. L’opera esprime i
tormenti e la complessità di un
artista che raffigura un mondo
edenico polinesiano. I protagonisti
assoluti, in questo caso,
antiteticamente rispetto
all’interpretazione fornita da
Dioscoro Puebla, sono gli autoctoni:
dodici figure rappresentanti le
varie fasce d’età, popolano, in una
lettura dell’opera da destra verso
sinistra, la tela. Nella parte
superiore del dipinto, a sinistra,
campeggiano le domande del titolo,
che completano l’opera nella forma e
nella sostanza.
Il dipinto nella rappresentazione
della cultura polinesiana,
simboleggia la vita nel dispiegarsi
delle varie fasi: a sinistra, un
bambino adagiato vicino a giovani
donne che ne vegliano il sonno. Due
di loro osservano lo spettatore; una
appare di profilo. Dietro di loro,
da un’oscura spelonca, affiorano
altre due donne avvolte da lunghe
tuniche e una figura di schiena con
la mano sul capo.
La scena centrale è occupata da un
giovane che raccoglie dei frutti
dalla cima di un albero. Verso
sinistra una bambina mangia un
frutto, mentre una donna seduta
accanto a un’anziana pare
simboleggiare il divario
generazionale e il placido scorrere
del tempo. Sullo sfondo un idolo
locale si trova vicino a un’altra
figura femminile, assorta nei propri
pensieri. Il mondo animale trova
ampio spazio, in un rapporto di
simbiosi con gli esseri umani. Sullo
sfondo la vegetazione endemica, il
mare e un’isola non sono semplice
ornamento, ma parte della
narrazione, dove il rapporto tra
esseri umani e natura è ancorato a
una purezza primitiva. Non si scorge
realismo, ma un'astrattezza delle
forme dettata dalla volontà del
pittore di conferire alla propria
rappresentazione artistica un tratto
istintivo aderente alle culture
indigene. Il dipinto presenta quasi
una dimensione onirica e lo stesso
utilizzo dei colori trasmette un’
atmosfera sospesa tra inconscio e
realtà in un chiaro intento di
sperimentazione libera dai vincoli
della rappresentazione tradizionale.
Gli itinerari nell’arte
rappresentano sempre nuovi approdi
verso mondi fisici e interiori,
punti di incontro tra culture,
frontiere estetiche ed emozionali.
L'uomo in epoche ancestrali viveva
sospeso tra gli elementi naturali,
che osservava con rispetto, timore e
soggezione religiosa. Il mare si
ergeva come barriera fisica e
mentale e affrontarlo costituiva una
sfida che richiedeva abilità e
coraggio, istinto e ragione: Odisseo
che affronta il dio Poseidone.
Attraversare il mare significava
solcare le insondabili praterie del
subconscio tra le tempeste interiori
delle debolezze umane. Eppure, il
crocevia di cultura e mercanzie è
l'esito dello spirito di adattamento
e della progressività insita
nell'umanità. Se il brigantino
Beagle di Charles Darwin può
assurgere a emblematico esempio
della spinta verso il progresso e
della fede nella scienza, la
baleniera Pequod descritta da
Melville in Moby Dick, diviene
metafora del viaggio come eterno
conflitto nel quale l’essere umano
scopre anche i territori inesplorati
della propria anima.
L’unico sopravvissuto del romanzo di
Melville, non a caso, si chiama
Ismaele: “Sostenuto da quella
bara, vagai alla deriva per quasi
tutto un giorno e una notte su un
mare morbido e funereo. I pescecani
mi guizzavano accanto senza
toccarmi, neanche avessero lucchetti
alla bocca; i selvaggi falchi marini
passavano coi becchi inguainati. Il
secondo giorno una vela si avvicinò,
si avvicinò sempre di più, e alla
fine mi raccolse. Era la Rachele,
che andava incrociando fuori rotta e
che, nel ritorno sui suoi passi in
cerca dei figli perduti, trovò
soltanto un altro orfano”. La
fine della storia non è stata ancora
avvistata dall'ultimo uomo, che per
natura cercherà sempre nuovi
orizzonti.
Riferimenti bibliografici:
Gombrich E.H., La storia
dell’arte, Phaidon, 2008.
Farthing S., Arte. La storia
completa, Atlante Srl,
Valsamoggia (Bo), 2018.
Farthing, S., 1001 dipinti. Una
guida completa ai capolavori della
pittura, Atlante Srl,
Valsamoggia (BO), 2021.
Antonini A., L’opera pittorica -
Vermeer, Rusconi Libri S.p.A.,
Stampato in India, 2018.
Erodoto, Le Storie, Libro II,
Antica Biblioteca Corigliano
Rossano, raccolta digitale
pubblicata nel 2022.
Fernández-Armesto F., Cristoforo
Colombo, RCS Quotidiani Spa,
Milano, 2005, edizione speciale per
il Corriere della Sera - Titolo
dell’edizione originale: Columbus.
Darwin C., Viaggio di un
naturalista intorno al mondo,
2005, ET Saggi
Melville H., Moby Dick,
Biblioteca Economica Newton, Prima
edizione: New Compton Editori srl,
Roma, 1995.
Rabino M., Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo? di Paul Gauguin,
ADO - analisi dell’opera, 2018:
https://www.analisidellopera.it/paul-gauguin-da-dove-veniamo-chi-siamo-dove-andiamo/